La carriera delle donne, anche nel settore della ricerca scientifica, è ostacolata dalla mancanza di pari opportunità. Per questo, dice la scienziata Elisabetta Dejana, bisogna cambiare mentalità e regole. Scommettendo sui giovani
 Elisabetta Dejana, professore Ordinario di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Milano, è una scienziata di fama internazionale specializzata nell’ambito della ricerca sulla formazione del sistema vascolare. È stata da poco premiata con il prestigioso premio Ippocrate, oltre che per la sua attività, per l’opera di divulgazione e informazione di cui è forte sostenitrice. Uno dei temi che le stanno più a cuore in ambito lavorativo sono i dati che confermano la disparità occupazionale uomo-donna anche nel suo settore. Per questo Dejana pensa sia necessario un vero cambiamento culturale: e questo non è un’utopia se si guarda all’esperienza di altri Paesi dove l’introduzione di alcune misure a favore delle donne ha accelerato un cambiamento che investe l’intera società.
Elisabetta Dejana, professore Ordinario di Patologia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomolecolari e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Milano, è una scienziata di fama internazionale specializzata nell’ambito della ricerca sulla formazione del sistema vascolare. È stata da poco premiata con il prestigioso premio Ippocrate, oltre che per la sua attività, per l’opera di divulgazione e informazione di cui è forte sostenitrice. Uno dei temi che le stanno più a cuore in ambito lavorativo sono i dati che confermano la disparità occupazionale uomo-donna anche nel suo settore. Per questo Dejana pensa sia necessario un vero cambiamento culturale: e questo non è un’utopia se si guarda all’esperienza di altri Paesi dove l’introduzione di alcune misure a favore delle donne ha accelerato un cambiamento che investe l’intera società.
Di che cosa si occupa nell’ambito della ricerca per la cura dei tumori?
Si tratta di un aspetto particolare della cura dei tumori, ossia la loro capacità di creare un proprio sistema vascolare che consente di convogliare su di sé il sangue, cioè il nutrimento e l’ossigeno, e quindi di crescere. Più di recente ci si è accorti che le cose funzionano in modo più complicato di quel che si può immaginare, per cui se esistono casi in cui lo sforzo è di tagliare i viveri ai tumori, ci sono anche condizioni in cui è addirittura preferibile aumentarne la vascolarizzazione per consentire ai farmaci di arrivare in modo più efficace. Il nostro tentativo è di trovare farmaci diversi per poterli adattare allo stadio di progressione del tumore. Il trattamento su misura è la parola d’ordine. E in questo campo la ricerca sembra ancora molto lunga.
Di recente le è stato conferito il “Premio Ippocrate”. Ci spiega le motivazioni di questo premio?
 Il premio è assegnato ai ricercatori che si sono distinti, oltre che la loro attività scientifica, per la capacità di promuovere i risultati dei loro studi. Credo sia cruciale nel mio lavoro curare l’aspetto di informazione e aggiornamento ed è quello che tento di fare attraverso la pubblicazione di articoli, l’attività divulgativa presso l’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) e l’organizzazione sistematica di seminari soprattutto rivolti ai giovani delle scuole e agli studenti di medicina. Come di recente mi è accaduto in un emozionante incontro a Napoli, alla presenza di almeno un migliaio di ragazzi ai quali, oltre a presentare quanto facciamo, ho cercato di comunicare quanto può essere bello fare un lavoro che tenta di curare una malattia così importante, quasi come se fossimo esploratori di mondi sconosciuti. Se consideriamo poi che la nostra ricerca è possibile farla grazie alle donazioni dei privati e a fondi pubblici comunitari e nazionali, penso sia una priorità, un vero e proprio dovere sociale far conoscere il più possibile come lavoriamo e quali sono i risultati raggiunti, perché il senso è che si tratta di uno sforzo comune che si fa insieme per migliorare la salute di tutti. Un’ultima considerazione: l’attività di divulgazione mi sembra importante anche per tentare di accrescere la cultura scientifica nel nostro paese, che invece non è né coltivata né molto considerata, partendo sin dai bambini, dai ragazzi e dagli insegnanti di materie scientifiche.
Il premio è assegnato ai ricercatori che si sono distinti, oltre che la loro attività scientifica, per la capacità di promuovere i risultati dei loro studi. Credo sia cruciale nel mio lavoro curare l’aspetto di informazione e aggiornamento ed è quello che tento di fare attraverso la pubblicazione di articoli, l’attività divulgativa presso l’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) e l’organizzazione sistematica di seminari soprattutto rivolti ai giovani delle scuole e agli studenti di medicina. Come di recente mi è accaduto in un emozionante incontro a Napoli, alla presenza di almeno un migliaio di ragazzi ai quali, oltre a presentare quanto facciamo, ho cercato di comunicare quanto può essere bello fare un lavoro che tenta di curare una malattia così importante, quasi come se fossimo esploratori di mondi sconosciuti. Se consideriamo poi che la nostra ricerca è possibile farla grazie alle donazioni dei privati e a fondi pubblici comunitari e nazionali, penso sia una priorità, un vero e proprio dovere sociale far conoscere il più possibile come lavoriamo e quali sono i risultati raggiunti, perché il senso è che si tratta di uno sforzo comune che si fa insieme per migliorare la salute di tutti. Un’ultima considerazione: l’attività di divulgazione mi sembra importante anche per tentare di accrescere la cultura scientifica nel nostro paese, che invece non è né coltivata né molto considerata, partendo sin dai bambini, dai ragazzi e dagli insegnanti di materie scientifiche.
Cosa pensa della situazione delle donne impegnate in un ambiente ancora a forte prevalenza maschile come quello della ricerca scientifica?
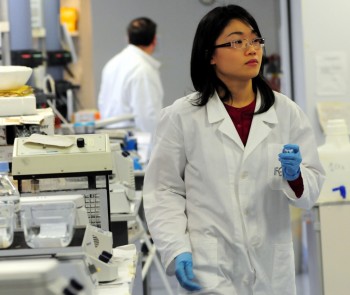 È noto che non c’è parità tra l’occupazione femminile e maschile, ma i dati che vado raccogliendo da qualche anno sono impressionanti anche nel mio settore. Le donne che si iscrivono alle facoltà scientifiche superano il 50 percento del totale, sono più brave degli uomini perché il 20 percento dei voti sono più alti, entrano poi nella carriera scientifica in numero consistente perché sono il 60 percento del totale, hanno una produzione scientifica equivalente se non superiore ai maschi, non si può dire che siano meno portate per le materie scientifiche perché non c’è alcuna evidenza che lo dimostri… nonostante tutto questo, via via che si sale nel percorso professionale, la presenza delle donne diminuisce in modo scandaloso. Al massimo della carriera scientifica la situazione si ribalta rispetto agli inizi, perché le donne sono ridotte al 15 percento del totale, tra i manager dell’industria farmaceutica che prendono decisioni le donne sono solo l’1 percento, i professori ordinari donne nell’Università italiana sono il 16 percento, al CNR le donne group leader sono il 10 percento del totale, solo due sugli oltre ottanta rettori delle facoltà italiane sono donne, e per finire gli stipendi sono mediamente il 30 percento in meno rispetto agli uomini. Questa inconfutabile situazione di non parità vale per l’Italia, ma è vera anche per l’Europa in genere e gli Stati uniti. All’Università di Harvard, le donne risultano più brave a raccogliere fondi che, vale la pena ricordarlo sono direttamente collegati alla produzione e alla qualità scientifica, eppure solo il 12 percento ha raggiunto il massimo della carriera come professore.
È noto che non c’è parità tra l’occupazione femminile e maschile, ma i dati che vado raccogliendo da qualche anno sono impressionanti anche nel mio settore. Le donne che si iscrivono alle facoltà scientifiche superano il 50 percento del totale, sono più brave degli uomini perché il 20 percento dei voti sono più alti, entrano poi nella carriera scientifica in numero consistente perché sono il 60 percento del totale, hanno una produzione scientifica equivalente se non superiore ai maschi, non si può dire che siano meno portate per le materie scientifiche perché non c’è alcuna evidenza che lo dimostri… nonostante tutto questo, via via che si sale nel percorso professionale, la presenza delle donne diminuisce in modo scandaloso. Al massimo della carriera scientifica la situazione si ribalta rispetto agli inizi, perché le donne sono ridotte al 15 percento del totale, tra i manager dell’industria farmaceutica che prendono decisioni le donne sono solo l’1 percento, i professori ordinari donne nell’Università italiana sono il 16 percento, al CNR le donne group leader sono il 10 percento del totale, solo due sugli oltre ottanta rettori delle facoltà italiane sono donne, e per finire gli stipendi sono mediamente il 30 percento in meno rispetto agli uomini. Questa inconfutabile situazione di non parità vale per l’Italia, ma è vera anche per l’Europa in genere e gli Stati uniti. All’Università di Harvard, le donne risultano più brave a raccogliere fondi che, vale la pena ricordarlo sono direttamente collegati alla produzione e alla qualità scientifica, eppure solo il 12 percento ha raggiunto il massimo della carriera come professore.
Sulla base della sua esperienza, quali sono i motivi che non consentono alle donne di essere presenti in modo adeguato nel settore della ricerca scientifica?
Penso che si possa uniformare tutto a un principio culturale, al ruolo maschile e femminile che si è perpetuato nel tempo e che assegna alla donna il mantenimento della continuità familiare e all’uomo il sostentamento fuori dalle mura domestiche. Differenza di ruoli che sono molto difficili da riportare in parità. Bisogna quindi agire per un cambio di mentalità. Perché il cervello non ha sesso, secondo uno slogan che ho usato in qualche seminario. Nell’intervista che avete fatto a Mara Gualandi, con la quale condivido molte cose, si dice che l’Unione europea vuole puntare su asili migliori, su una migliore organizzazione per accudire gli anziani e così via. Tutti interventi positivi ma non sono del tutto d’accordo che sia il modo migliore per agire da un punto di vista culturale perché si da sempre per scontato che sia la donna a occuparsi di questi aspetti. La maternità poi è un punto focale, perché sono convinta che crescere i figli non sia solo compito e responsabilità femminile. In questo modo si perpetua l’idea che le donne sul posto di lavoro non siano affidabili perché non sono in grado di garantire una presenza costante e si finisce per penalizzarle dal punto di vista professionale.
E allora su quali aspetti prioritari, secondo lei, si potrebbe far leva per invertire la tendenza?
Tutti noi, soprattutto le donne impegnate nel settore della ricerca, stiamo riflettendo su questa situazione per cercare di trovare proposte concrete per modificarla. Sono convinta che, come dicevo prima, sia necessario agire sul cambiamento culturale, anche delle donne, facendo leva sul loro desiderio di costruirsi una carriera, sull’importanza del sostegno da parte del tutor che spesso è ancora scelto di sesso maschile perché ritenuto più forte a livello “politico”, sulla necessità di un atteggiamento più collaborativo tra donne. Le giovani, a parità di formazione, si fanno avanti molto meno: nei comitati scientifici di cui faccio parte a livello europeo, le ricercatrici che fanno domande per avere finanziamenti sono meno dei ragazzi, nonostante abbiamo visto quanto siano numerose e anche molto brave. È necessario stimolare una diversa mentalità delle donne giovani, anche portando come testimonianza i casi di scienziate affermate per convincerle che “ce la possiamo fare”. Anche a livello politico credo sia fondamentale puntare su azioni in grado di smuovere l’approccio culturale: il congedo parentale obbligatorio anche per gli uomini, e non facoltativo come è oggi, è fondamentale per cambiare la mentalità dei padri e per appianare il perenne senso di colpa delle madri. Se guardo al caso della Norvegia e della Svezia dove questo obbligo è stato introdotto, i risultati sono clamorosi. Le stesse quota-rosa sulle quali, anche giustamente, ci sono riserve, sono convinta che però servirebbero proprio ad accelerare un modo di pensare diverso, più paritario. E poi, oltre ad un partner sensibile e collaborativo che è indispensabile, sono sicuramente favorevole alla diffusione degli strumenti sociali che possano aiutare le donne nella loro quotidianità e, ad esempio, nel mio settore propongo siano creati laboratori specifici dove le donne incinte possano continuare a lavorare lontane da sostanze pericolose per la loro salute, senza essere costrette a stare a casa prima del tempo.
Un mondo del lavoro con più donne sarebbe diverso?
Non solo sarebbe più corretto, ma sicuramente sarebbe migliore. Di questo sono fermamente convinta. Faccio degli esempi concreti: sicuramente le riunioni di lavoro sarebbero più brevi e concrete, diminuirebbero i contrasti vista la nostra più alta capacità di mediare, i viaggi di lavoro si farebbero solo se necessari, e non solo per motivi economici ma proprio per la mentalità delle donne abituate a organizzare meglio il tempo a loro disposizione.
La sua storia professionale e i risultati raggiunti sembrano un’eccezione. Ma dal punto di vista personale, perché è rimasta in Italia a lavorare?
Personalmente non ho vissuto sulla mia pelle discriminazioni in quanto donna, ma rimane sempre l’elemento culturale che tutte noi viviamo quotidianamente. Se pensiamo al direttore di un laboratorio scientifico, chissà perché l’associazione è sempre con una persona di sesso maschile… Ma le cose possono cambiare. Quanto al mio restare in Italia, devo dire che, dopo le esperienze in Canada e in Francia, ho deciso di tornare qui perché stava partendo l’esperienza interessante del campus dell’Ifom, dove continuo a lavorare molto bene. E poi c’è una questione di radici, di appartenenza al proprio Paese nei cui confronti esiste il desiderio di fare qualcosa di positivo e costruttivo. Ma i giovani ricercatori oggi, se ne hanno le possibilità, vanno all’estero perché ritengono che lo sviluppo della loro carriera in Italia non sia garantito. In questo modo non potenziamo la ricerca di base che è fondamentale per la crescita di un paese. Ad esempio la Finlandia, in pochi anni, investendo sulla ricerca e la tecnologia, è riuscita ad ottenere elevati tassi di crescita del Pil. Se si fanno investimenti a sostegno di una ricerca fatta bene, i ritorni sono scontati. Invece accade che a ricercatori giovani e molto bravi, dopo tanto studiare, venga tolta la speranza sul loro futuro lavorativo costringendoli ad andare all’estero con un danno, anche in termini economici, per l’intero paese che non rientra in modo congruo degli investimenti fatti sulla formazione.





