In quasi 40 anni di lavoro con i giovani, è stato testimone di drammi e vite difficili, ma ha dimostrato che è possibile cambiare rotta. A patto che gli adulti imparino ad ascoltare. Perché a spingere un ragazzo alla violenza, oggi, più che la povertà, sono la mancanza di valori e la solitudine
L’anno scorso ha compiuto settant’anni e i suoi amici hanno organizzato per lui una grande festa a sorpresa proprio lì, al Beccaria, il carcere minorile di Milano, dove lavora e lotta da tutta una vita. Virginio Rigoldi, per tutti Gino, è nato a Milano nel quartiere di Crescenzago. A tredici anni comincia a lavorare come operaio in una fabbrica di apparecchiature elettriche e a diciotto entra in seminario; nel 1972 don Gino chiede e ottiene di diventare cappellano dell’Istituto penale per minorenni «Cesare Beccaria» di Milano. Da allora, quei ragazzi non li ha più lasciati. Quelli che i reati li commettono. E che poi pagano.
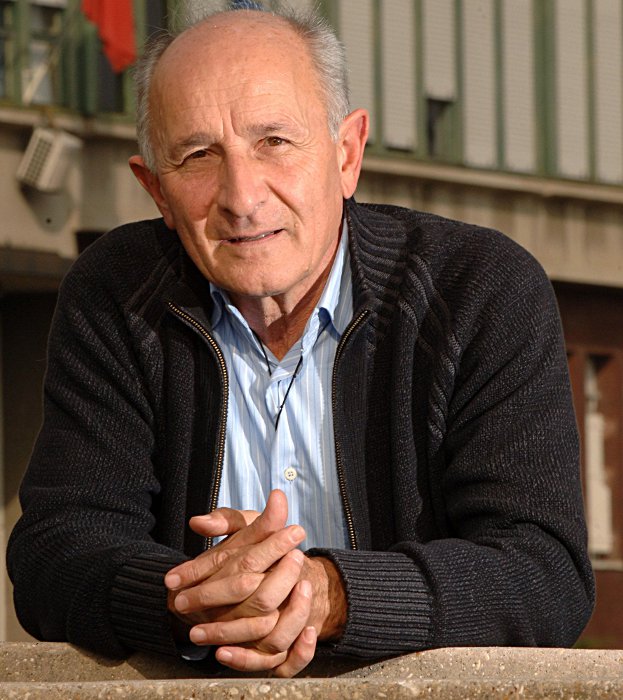 Trentotto anni vissuti fianco a fianco con i giovani detenuti del Beccaria. Quali cambiamenti ci sono stati in questo lungo periodo?
Trentotto anni vissuti fianco a fianco con i giovani detenuti del Beccaria. Quali cambiamenti ci sono stati in questo lungo periodo?
Ho cominciato a fare il cappellano nel 1972; allora c’erano soltanto ragazzi italiani, gli stranieri sono arrivati nei primi anni ’90. Mediamente entravano mille ragazzi l’anno e oltre il 90 per cento proveniva da famiglie di immigrati del sud Italia, appena arrivati oppure di prima generazione. Quasi tutti abitavano nei quartieri della periferia costruiti proprio per l’accoglienza e portavano con sè tipologie di delinquenza diverse a seconda del quartiere di provenienza; per esempio in Comasina c’erano i rapinatori, è da lì che veniva Vallanzasca, Quarto Oggiaro invece era la zona degli spacciatori. Oggi come trent’anni fa chi arriva in carcere fa vedere i muscoli. Erano ragazzi decisi, aggressivi, pronti a menar le mani, dovevano ottenere soldi in fretta; ma c’era anche l’eterno bisogno dei giovani di realizzare un’impresa per dimostrare al mondo di esistere. Del resto gli adolescenti hanno sempre avuto bisogno di essere riconosciuti.
Qual è invece la situazione oggi?
I numeri al Beccaria si sono ridimensionati: annualmente abbiamo circa 300 ragazzi che arrivano nella sezione carceraria; ma se fino a qualche anno fa la maggioranza era costituita da immigrati stranieri, oggi più della metà sono italiani. L’aumento del numero di detenuti italiani va letto con una lente particolare. Rispetto ai loro coetanei stranieri, infatti, non essendoci il problema della clandestinità, hanno più possibilità di ricorrere a misure alternative: andare in comunità, essere affidati ai servizi sociali o, se la famiglia non è troppo disastrata, scontare la pena ai domiciliari. I reati più comuni sono sempre rapina e spaccio, ma quello che preoccupa è la modalità violenta, che porta appunto a condanne così alte da non poter essere scontate con misure alternative.
 Se per gli immigrati la criminalità è spesso legata a povertà materiale ed emarginazione, per gli italiani la delinquenza è soprattutto dovuta a una povertà di valori, è diventata una forma di affermazione di sé, un modo per sentirsi forti a spese degli altri, delle vittime. Quello che conta è ciò che devono assolutamente possedere e il furto o la rapina diventano solo un modo veloce per procurarselo.
Se per gli immigrati la criminalità è spesso legata a povertà materiale ed emarginazione, per gli italiani la delinquenza è soprattutto dovuta a una povertà di valori, è diventata una forma di affermazione di sé, un modo per sentirsi forti a spese degli altri, delle vittime. Quello che conta è ciò che devono assolutamente possedere e il furto o la rapina diventano solo un modo veloce per procurarselo.
Fino a 15 anni fa non era difficile arrivare a far sì che il ragazzo si pentisse; oggi faccio molta fatica a ottenere che si rendano conto di aver offeso il diritto, la dignità di una persona. Il problema maggiore è proprio questo: il valore degli altri non lo sentono. Vedo arrivare giovani dalle periferie, con un’educazione povera e famiglie disattente, come quelli di 30 anni fa. Ma oggi i ragazzi hanno qualcosa in meno di allora: sono depressi, spenti, gli manca una visione positiva del futuro. Gli adolescenti sono lasciati soli: Milano è diventata una città piena di orfani.
Contemporaneamente al suo impegno all’interno del Beccaria è nato quello nella città, con le comunità alloggio e il lavoro dell’associazione Comunità Nuova.
Quando mi sono accorto che, una volta usciti dal Beccaria, molti ragazzi non sapevano dove andare, ho incominciato a ospitarli a casa mia. Prima dieci, poi venti. Quando sono arrivato a trenta mi sono detto che così non si poteva andare avanti. Ed è nata la prima comunità alloggio, quattro stanze in affitto al quartiere Isola, dietro la stazione Garibaldi, gestita con l’aiuto di volontari ed educatori insieme ai quali avevo fondato l’associazione Comunità Nuova. E subito dopo, notando che la maggior parte dei ragazzi arrivava dalle periferie, ho capito che era giusto andare sul posto a fare qualcosa e aprimmo un centro giovanile a Baggio. Uno spazio di 150 metri quadri e il sabato sera arrivavano fino a 400 ragazzi, una roba da non potersi muovere, con gli autobus che dovevano cambiare percorso perché era tanta la gente che non riuscivano più a passare in quella strada! Oggi Comunità Nuova è diventata una vasta struttura organizzata che si occupa del recupero dei minori, delle tossicodipendenze, dell’immigrazione.
È ottimista per il futuro dei suoi ragazzi?
I giovani sono persone in evoluzione, per questo una caduta non è definitiva, c’è sempre una possibilità di recupero se si ha voglia di scommettere sulle loro risorse. Hanno bisogno di adulti che li ascoltino davvero, che gli trasmettano qualcosa in cui credere. Sono andato a migliaia di incontri nelle scuole, negli oratori, nelle società sportive e sono certo che in Italia abbiamo ancora una bella gioventù, capace di entusiasmi, ideali, sacrifici per una causa. Non ne posso più delle drammatiche denunce di gravi problemi che poi si fermano lì: io penso e agisco con la convinzione, forse semplicistica, che tutti i problemi sono fatti per essere risolti. Dai Vangeli non si ricava che Gesù fosse prudente e perbene. Lo fosse stato, sarebbe morto di vecchiaia.





